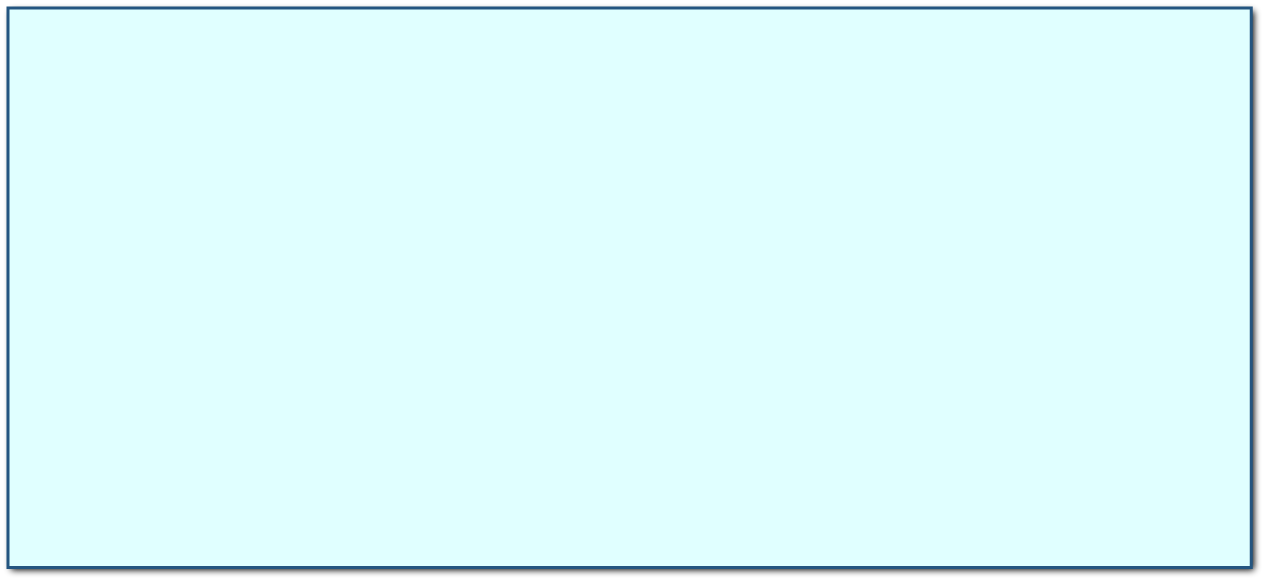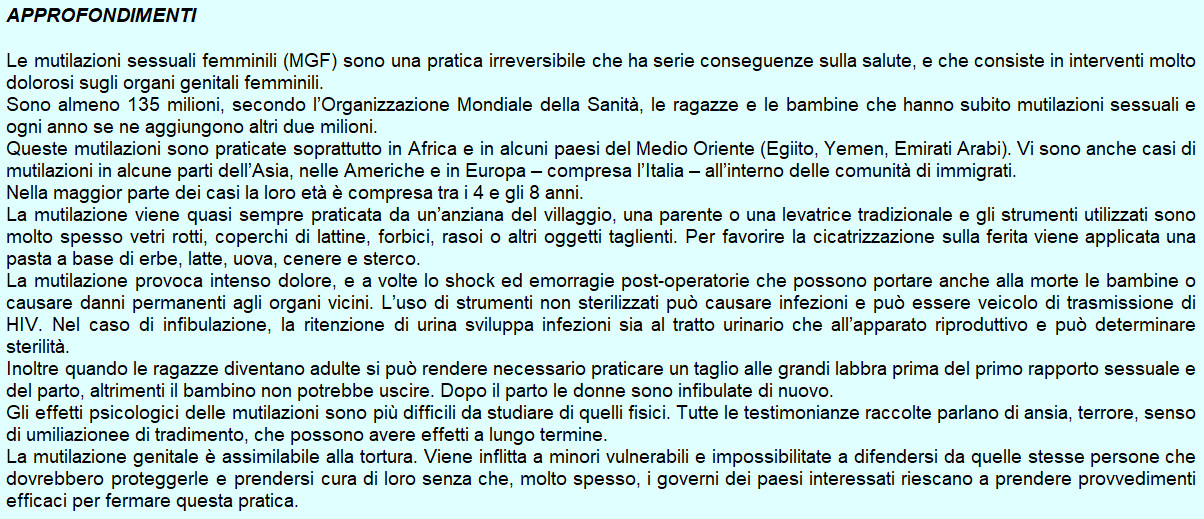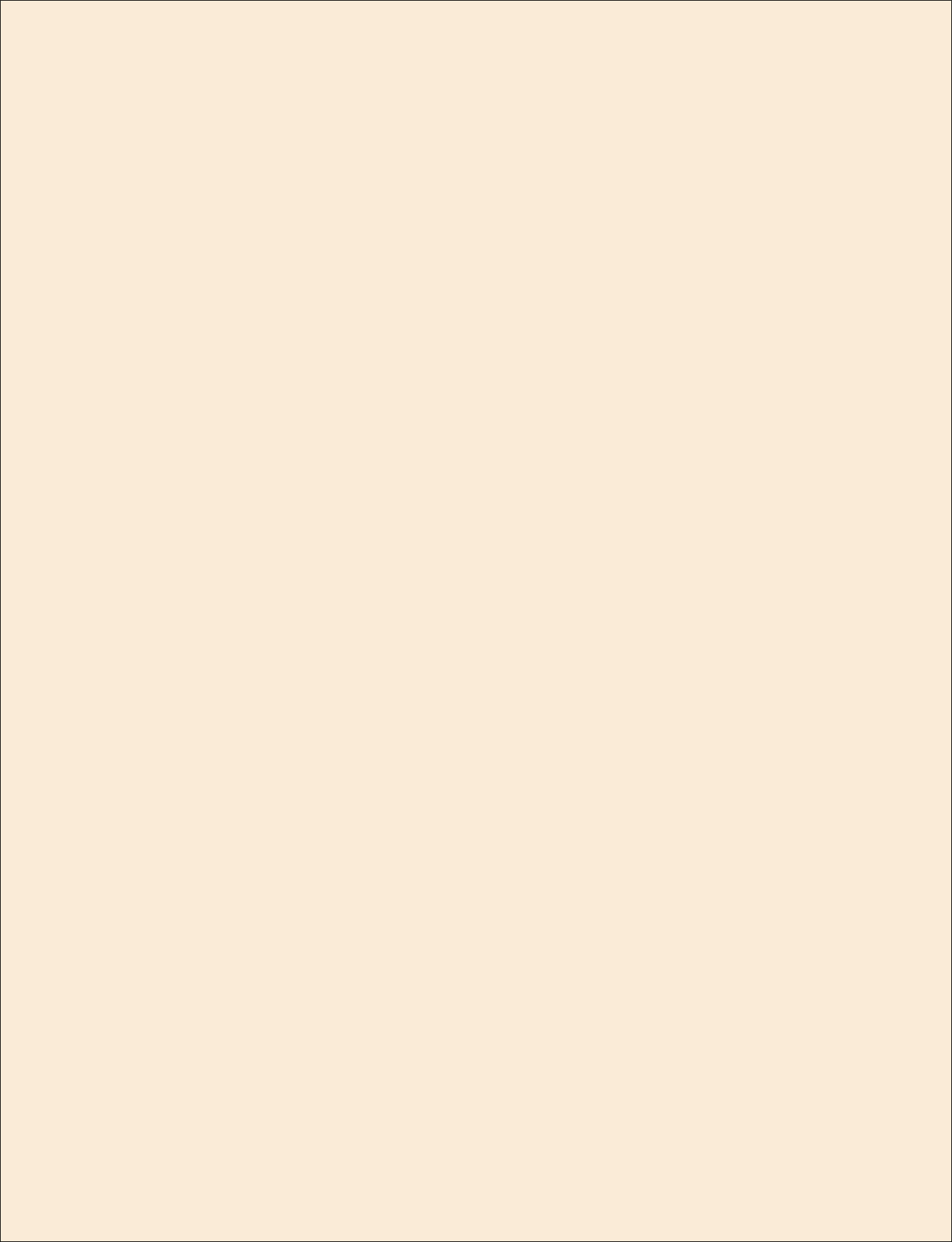

Non riusciva più a farne a meno. A dormire senza la sua bambolina di stoffa
coi capelli di lana riccia, morbidi e aggrovigliati come una matassa.
Le piaceva quella bambolina, anche perché aveva la pelle scura come la sua ed
I vestiti di cotonina a fiori vivaci, come quelli delle sue parti.
Un’altra cosa di cui non riusciva a fare a meno era dormire con la luce accesa, quando l’angoscia l’assaliva.
Una piccola luce che le ricordava il chiarore che penetrava dalle fessure della
capanna del suo villaggio quando, con gli occhi sbarrati dal sonno che tardava
a venire, ascoltava i canti provenire dalla zona bassa, là accanto al grande fiume.
Le piaceva anche fare scorrere velocemente le dita su qualsiasi cancello, o inferriata accanto al quale le capitava di passare. Le piaceva far vibrare in sequenza tutte quelle aste di ferro: era un gioco che Salima faceva sempre col suo cuginetto pronunciando le formule magiche che avevano sentito recitare dagli anziani storpiandone le parole.
Ma Salima non lo sapeva.
Non sapeva che un giorno avrebbe lasciato tutto questo. E che i suoni, gli umori, i colori della sua terra sarebbero a poco a poco diventati un inutile balbettio, sempre più fioco e lontano.
Adesso esisteva la Casa accogliente, piena di luci e di spazi così diversi da quelli a cui era abituata.
Adesso c’erano Ingrid e suor Maria e la dottoressa Carla, che se non fosse stato per quella pelle così ridicolmente bianca, sarebbero state bellissime.
Non come lei, Salima, o Agadir o Yusuf che avevano la pelle scura e le labbra grosse e gli occhi neri come i datteri essiccati al sole.
Qualcuno l’aveva afferrata quella sera, afferrata e portata via dopo un trambusto violento di cui ricordava solo il rumore degli spari e la polvere. Polvere su tutto: sulle capanne, sugli abbeveratoi degli animali, sugli orti recintati da steccati di legno su cui, con le dita della mano faceva quel gioco che le piaceva tanto. Non era in grado di capire cosa fosse successo. Sapeva solo che non c’erano più sua mamma, e i sui cuginetti che giocavano con lei sullo spazio antistante alle capanne.
L’aereo, poi. Una lingua sconosciuta, poi. Visi sconosciuti, incredibilmente chiari, ma sorridenti e disponibili, poi.
La sua piccola vita sradicata e smembrata si era adagiata quietamente in una dimensione così lontana…
Le piaceva quando Ingrid - che le aveva fatto tante domande e scarabocchiava qualcosa su dei fogli misteriosi che teneva gelosamente con sé - prendeva un libro grande, lo apriva proprio nel punto in cui c’era l’immagine della sua terra – l’Africa la chiamava lei - e Salima vedeva una forma tozza circondata dal blu, divisa all’interno in tanti quadratini colorati.
In uno di questi quadratini era nata lei, Salima.
Le piaceva quando Ingrid si sedeva accanto a lei, le apriva il quaderno e guidava la sua mano sulle lettere che lei doveva pronunciare e anche scrivere, poi. Il suo piccolo dito nero scorreva su quei segni. La sua voce cercava di riprodurre quei suoni.
Com’era diversa la sua vita in Africa!
I gesti, le parole, le abitudini, così lontane dalle sue che a volte non riusciva più a ricostruire quale fosse la vera realtà: se quella vissuta lì, ora, in quella dimensione così asettica, ma rassicurante, o in quegli sprazzi caotici e umorali che ogni tanto emergevano galleggiando in una zona indeterminata della sua coscienza.
Poi c’era il bruciore. E il fastidio: insopportabile, a volte. La dottoressa Carla ogni tanto la guardava lì sotto, la scrutava attentamente con degli strani strumenti che Salima non aveva mai visto. Sorrideva la dottoressa Carla, ma con aria un po’ preoccupata e confabulava con Ingrid su qualcosa che in seguito, si sarebbe dovuto fare…
Quel giorno fare qualsiasi movimento le era venuto difficilissimo e il dolore al basso ventre acuto e costante: non aveva quasi giocato né studiato con i numeri e le lettere. Si trascinava lungo le pareti tenendosi stretta la sua bambolina. Le avevano dato qualcosa per alleviare il fastidio e s’era messa così, a letto prima del tempo, accovacciata su un fianco come un animaletto ferito.
Era sopraggiunto un sonno nero e pesante.
Si vedeva trascinata da due donne del villaggio in una casupola buia vicino al fiume. Tra canti e riti propiziatori l’avevano denudata, bendata e costretta a sdraiarsi sulla schiena. Le due donne le tenevano saldamente le gambe e una terza, poi, con qualcosa di tagliente incideva lì, in mezzo alle gambe, mentre un liquido caldo le usciva e colava dappertutto…
Salima aveva urlato allora: un urlo roco e prolungato che veniva fuori con forza inaspettata, da quel corpicino martoriato.
Lo stesso urlo che l’aveva svegliata, nel cuore della notte, intontita e febbricitante.
Erano venute subito a soccorrerla, la dottoressa Carla e suor Maria: i visi ansiosi su di lei, le mani sotto la sua testa. La rassicuravano dicendole che non era successo niente, che aveva solo fatto un brutto sogno. Un incubo, dicevano loro.
Di non preoccuparsi, che col tempo e quando…non avrebbe avuto più nessun fastidio, che ci voleva pazienza, tanta pazienza…
E Salima a poco a poco si era acquietata. I singulti si erano trasformati in respiri sempre più regolari, fino al sonno.
Quando suor Maria era venuta a vederla, l’indomani, aveva notato la bambolina di pezza che Salima teneva per un braccio, facendola penzolare giù dal letto. In mezzo all’attaccatura delle due gambe fuorusciva un po’ di ovatta del riempimento.
Da uno strappo fatto proprio là, in mezzo alle gambe.
coi capelli di lana riccia, morbidi e aggrovigliati come una matassa.
Le piaceva quella bambolina, anche perché aveva la pelle scura come la sua ed
I vestiti di cotonina a fiori vivaci, come quelli delle sue parti.
Un’altra cosa di cui non riusciva a fare a meno era dormire con la luce accesa, quando l’angoscia l’assaliva.
Una piccola luce che le ricordava il chiarore che penetrava dalle fessure della
capanna del suo villaggio quando, con gli occhi sbarrati dal sonno che tardava
a venire, ascoltava i canti provenire dalla zona bassa, là accanto al grande fiume.
Le piaceva anche fare scorrere velocemente le dita su qualsiasi cancello, o inferriata accanto al quale le capitava di passare. Le piaceva far vibrare in sequenza tutte quelle aste di ferro: era un gioco che Salima faceva sempre col suo cuginetto pronunciando le formule magiche che avevano sentito recitare dagli anziani storpiandone le parole.
Ma Salima non lo sapeva.
Non sapeva che un giorno avrebbe lasciato tutto questo. E che i suoni, gli umori, i colori della sua terra sarebbero a poco a poco diventati un inutile balbettio, sempre più fioco e lontano.
Adesso esisteva la Casa accogliente, piena di luci e di spazi così diversi da quelli a cui era abituata.
Adesso c’erano Ingrid e suor Maria e la dottoressa Carla, che se non fosse stato per quella pelle così ridicolmente bianca, sarebbero state bellissime.
Non come lei, Salima, o Agadir o Yusuf che avevano la pelle scura e le labbra grosse e gli occhi neri come i datteri essiccati al sole.
Qualcuno l’aveva afferrata quella sera, afferrata e portata via dopo un trambusto violento di cui ricordava solo il rumore degli spari e la polvere. Polvere su tutto: sulle capanne, sugli abbeveratoi degli animali, sugli orti recintati da steccati di legno su cui, con le dita della mano faceva quel gioco che le piaceva tanto. Non era in grado di capire cosa fosse successo. Sapeva solo che non c’erano più sua mamma, e i sui cuginetti che giocavano con lei sullo spazio antistante alle capanne.
L’aereo, poi. Una lingua sconosciuta, poi. Visi sconosciuti, incredibilmente chiari, ma sorridenti e disponibili, poi.
La sua piccola vita sradicata e smembrata si era adagiata quietamente in una dimensione così lontana…
Le piaceva quando Ingrid - che le aveva fatto tante domande e scarabocchiava qualcosa su dei fogli misteriosi che teneva gelosamente con sé - prendeva un libro grande, lo apriva proprio nel punto in cui c’era l’immagine della sua terra – l’Africa la chiamava lei - e Salima vedeva una forma tozza circondata dal blu, divisa all’interno in tanti quadratini colorati.
In uno di questi quadratini era nata lei, Salima.
Le piaceva quando Ingrid si sedeva accanto a lei, le apriva il quaderno e guidava la sua mano sulle lettere che lei doveva pronunciare e anche scrivere, poi. Il suo piccolo dito nero scorreva su quei segni. La sua voce cercava di riprodurre quei suoni.
Com’era diversa la sua vita in Africa!
I gesti, le parole, le abitudini, così lontane dalle sue che a volte non riusciva più a ricostruire quale fosse la vera realtà: se quella vissuta lì, ora, in quella dimensione così asettica, ma rassicurante, o in quegli sprazzi caotici e umorali che ogni tanto emergevano galleggiando in una zona indeterminata della sua coscienza.
Poi c’era il bruciore. E il fastidio: insopportabile, a volte. La dottoressa Carla ogni tanto la guardava lì sotto, la scrutava attentamente con degli strani strumenti che Salima non aveva mai visto. Sorrideva la dottoressa Carla, ma con aria un po’ preoccupata e confabulava con Ingrid su qualcosa che in seguito, si sarebbe dovuto fare…
Quel giorno fare qualsiasi movimento le era venuto difficilissimo e il dolore al basso ventre acuto e costante: non aveva quasi giocato né studiato con i numeri e le lettere. Si trascinava lungo le pareti tenendosi stretta la sua bambolina. Le avevano dato qualcosa per alleviare il fastidio e s’era messa così, a letto prima del tempo, accovacciata su un fianco come un animaletto ferito.
Era sopraggiunto un sonno nero e pesante.
Si vedeva trascinata da due donne del villaggio in una casupola buia vicino al fiume. Tra canti e riti propiziatori l’avevano denudata, bendata e costretta a sdraiarsi sulla schiena. Le due donne le tenevano saldamente le gambe e una terza, poi, con qualcosa di tagliente incideva lì, in mezzo alle gambe, mentre un liquido caldo le usciva e colava dappertutto…
Salima aveva urlato allora: un urlo roco e prolungato che veniva fuori con forza inaspettata, da quel corpicino martoriato.
Lo stesso urlo che l’aveva svegliata, nel cuore della notte, intontita e febbricitante.
Erano venute subito a soccorrerla, la dottoressa Carla e suor Maria: i visi ansiosi su di lei, le mani sotto la sua testa. La rassicuravano dicendole che non era successo niente, che aveva solo fatto un brutto sogno. Un incubo, dicevano loro.
Di non preoccuparsi, che col tempo e quando…non avrebbe avuto più nessun fastidio, che ci voleva pazienza, tanta pazienza…
E Salima a poco a poco si era acquietata. I singulti si erano trasformati in respiri sempre più regolari, fino al sonno.
Quando suor Maria era venuta a vederla, l’indomani, aveva notato la bambolina di pezza che Salima teneva per un braccio, facendola penzolare giù dal letto. In mezzo all’attaccatura delle due gambe fuorusciva un po’ di ovatta del riempimento.
Da uno strappo fatto proprio là, in mezzo alle gambe.
powered by Guido Scuderi
Estratto da “La bambola graffiata”